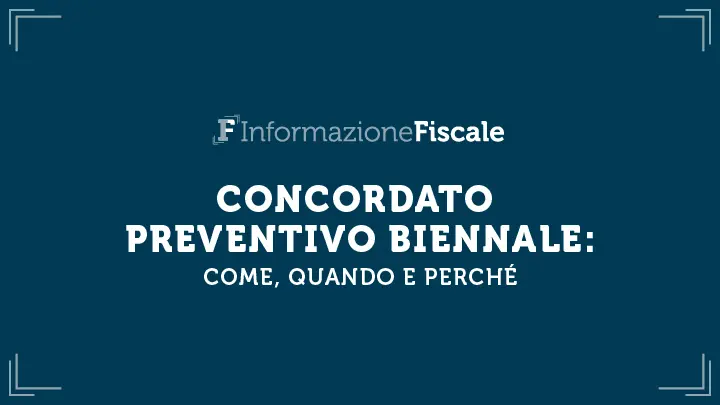Concordato preventivo biennale: uno strumento dalle potenzialità interessanti, che apparentemente sembra poco apprezzato da contribuenti e operatori professionali. Ma è proprio così?

I risultati delle adesioni al concordato preventivo biennale pervenute per il biennio 2025/2026 sembrano apparentemente tradire le attese del Governo circa questo strumento introdotto nell’ambito della riforma fiscale a cui si è affidato il duplice compito di accompagnare i contribuenti meno virtuosi verso un risultato più consono alle attese del Fisco e di premiare chi virtuoso già lo è.
Le prime indicazioni sembrano convergere su un numero di adesioni intorno ai 55.000, il 2 per cento del numero dei contribuenti ISA potenziali fruitori che sono poco più di 2,7 milioni, se ci fermiamo al dato statistico del 2023 pubblicato lo scorso fine maggio dal Dipartimento delle Finanze del MEF.
Esito che sommato a quelle della precedente tornata, circa 461.000 i soggetti ISA che hanno aderito entro il 12 dicembre 2024, porterebbe il risultato dal 17 per cento del biennio 2024/25 ad un 19 per cento complessivo, un dato che qualcuno potrebbe leggere anche positivamente ma che poteva essere ben più alto.
Concordato preventivo biennale: il bilancio dopo un anno di vita
Il concordato preventivo biennale è di fatto il tentativo di rilanciare una idea già perseguita vent’anni fa circa dall’allora Ministro delle Finanze Giulio Tremonti, una rivoluzione in materia fiscale considerando il suo obiettivo di render più trasparente il rapporto tra Fisco e Contribuente.
Con il CPB si cerca di stimolare un rapporto di cooperazione e collaborazione reciproca, incentivando in tal modo l’assolvimento spontaneo degli obblighi tributari e favorendo l’emersione spontanea di base imponibile fino ad oggi “sommersa”.
In effetti alla sua presentazione nella seconda metà del 2023 si poteva leggere più come uno strumento premiale essendo rivolto a coloro che avevano conseguito un soddisfacente risultato ISA dall’8 in su.
Le spinte degli operatori del settore e delle categorie economiche nonché di parte del Parlamento ne hanno ampliato la platea dei fruitori anche a coloro che non avevano conseguito tale risultato e finanche in via sperimentale ai soggetti che applicavano il regime forfetario, possibilità eliminata da questo secondo anno di applicazione.
Secondo biennio per la cui adesione sono state introdotte nuove cause di decadenza e cessazione e una limitazione degli incrementi di reddito proposti a favore dei contribuenti con voto ISA 8 o superiore, reintroducendo così la connotazione premiale iniziale caratteristica di questo istituto.
Quali elementi hanno frenato l’adesione al concordato preventivo biennale?
Proviamo a capire il perché di questi risultati apparentemente non così rosei.
Cominciamo col dire che l’adesione, comportando un impegno biennale deve necessariamente confrontarsi con l’andamento futuro a medio termine del proprio mercato di riferimento ed obiettivamente la congiuntura economica internazionale, non ha certo aiutato.
Ci si deve confrontare con attese della crescita del nostro PIL intorno all’1 per cento confermate anche nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica del 2025 trasmesso alle Camere il 2 Ottobre scorso.
Vi è anche una certa ritrosia di carattere etico che pure ha influenzato coloro che lo hanno bocciato sul nascere ritenendolo un premio ai contribuenti più facoltosi che si vedono ridurre dal Legislatore il proprio carico fiscale.
Mettiamoci anche una certa articolazione della norma ancora oggi non così chiara in diversi punti e non solo per i contribuenti, ma anche per le agenzie fiscali che sono tenute ad applicare la norma, ma della quale hanno la responsabilità di dettare la prassi di riferimento a cui la maggior parte dei contribuenti sceglie di attenersi pedissequamente per evitare contenziosi.
Concordato preventivo biennale: ci sono ancora nodi da sciogliere
Si veda il caso del “conferimento” come causa di cessazione degli effetti dell’accordo con il Fisco.
Una lettura fornita dall’Agenzia delle Entrate a inizio 2025 aveva dato una indicazione estensiva del significato, mettendo in allarme anche chi aveva conferito del denaro in società. L’interpretazione è stata successivamente cassata dal Legislatore con l’emanazione di una norma di interpretazione autentica che ne ha definito l’applicazione al solo caso di conferimento di aziende.
Oggi non abbiamo ancora certezza applicativa della norma in diversi casi, che potrebbero sembrare particolari ma che in realtà non sono così marginali.
Si pensi a chi ha sottoscritto l’accordo erroneamente non avendone i requisiti, anche qui l’Agenzia si è pronunciata dichiarandola causa di decadenza, ampliando il perimetro indicato dalla norma ma, ad avviso di chi scrive, andando oltre il dettato del Legislatore.
Sono solo un paio di esempi ma già questi possono rendere l’idea di come l’adesione al CPB nasconda non solo delle insidie collegate alla “scommessa sul futuro” della propria attività ma anche una “scommessa sul presente” dettato da una interpretazione della norma e una lettura della prassi che non hanno ancora un riscontro certo da parte della dottrina, divisa su diversi punti, e dalla giurisprudenza, assente per la gioventù dell’istituto.
Il dato sulle adesioni, complessivamente arrivate al 19 per cento, potrebbe essere letto paradossalmente in senso positivo, avendo conseguito questo risultato pur in presenza delle concause sopra citate, che hanno lavorato per scoraggiare il contribuente verso una scelta non solo volta al risparmio fiscale ma anche verso la certezza degli impegni finanziari a cui dover far fronte. Un risultato da conservare e da cui ripartire.
In tale direzione il Legislatore per dare nuovo impulso all’istituto potrebbe fornire strumenti necessari per dissipare i dubbi applicativi sui punti ancora poco chiari del CPB come pure, ribadendo una proposta già formulata dall’Istituto Nazionale Tributaristi fin dallo scorso anno, prevedere una premialità per coloro che intendano confermare l’adesione per il biennio successivo così da conservare questo primo nucleo di soggetti aderenti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Concordato preventivo biennale: un’analisi dei dati