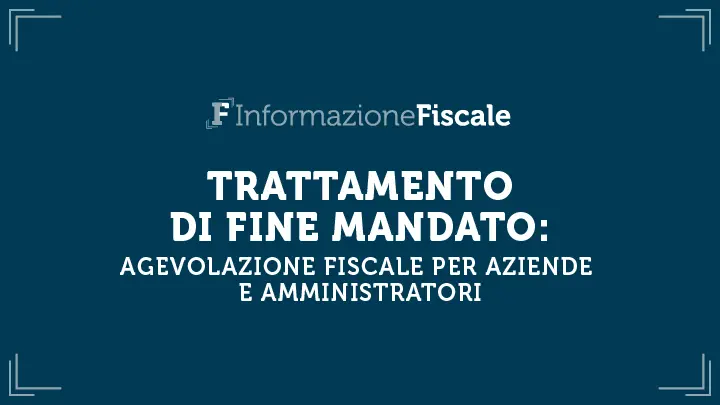Il trattamento fiscale del TFM nella dichiarazione dei redditi della società e degli amministratori

Il Trattamento di Fine Mandato (TFM) è un’indennità aggiuntiva, non obbligatoria, erogata agli amministratori delle società al termine del loro mandato.
A differenza del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dei lavoratori dipendenti, il TFM non è disciplinato da una norma specifica, ma trae origine dal combinato disposto degli articoli 2120 e 2364 del Codice Civile.
La sua previsione è facoltativa e deve essere stabilita nell’atto costitutivo o tramite delibera assembleare.
Rappresenta una voce di costo deducibile per la società e un compenso differito per l’amministratore, soggetto a tassazione potenzialmente agevolata, nel rispetto di precise condizioni.
Requisiti per la deducibilità del TFM per la società: il problema della data certa
Il TFM, per la società, è deducibile sotto forma di accantonamenti annuali, a condizione che venga rispettato il requisito della data certa. Invero, sulle condizioni che consentono la deducibilità dell’accantonamento, in luogo della deduzione integrale all’atto dell’erogazione, si è sviluppato un intenso dibattito tra l’Amministrazione Finanziaria e la giurisprudenza.
Secondo la posizione dell’Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza prevalente, la data certa è essenziale.
In sintesi, l’Agenzia delle Entrate sostiene che la deducibilità per competenza degli accantonamenti al TFM è riconosciuta solo se le indennità sono previste e quantificate per iscritto da un atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto.
In mancanza di tale atto, il TFM sarebbe deducibile unicamente per cassa, ovvero al momento dell’effettivo pagamento. Questa interpretazione si fonda sul richiamo dell’art. 105, comma 4, del TUIR all’art. 17, comma 1, lettera c) del TUIR, che l’Agenzia considera un riferimento implicito alle condizioni ivi previste, inclusa la data certa. Tale posizione è stata consolidata da diverse pronunce giurisprudenziali, tra cui la Corte di Cassazione nella sentenza n. 26431 del 19.10.2018 e, più recentemente, l’Ordinanza n. 19445 del 10 luglio 2023, che ha ribadito la necessità della data certa ai fini della deducibilità per la società e della tassazione separata per l’amministratore. La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 211 del 22.05.2008 e la Risoluzione n. 124 del 13.10.2017 sono ulteriori riferimenti chiave a supporto di questa interpretazione.
Di contro, alcuni pronunciamenti giurisprudenziali hanno adottato una posizione più flessibile. Ad esempio, la Cassazione nella sentenza n. 24848/2020 e le Corti di Giustizia Tributaria (come la CGT II grado Piemonte nelle sentenze n. 36 e 37 del 30.01.2024) hanno sostenuto che l’accantonamento al TFM dovrebbe essere deducibile per competenza in ciascun esercizio in base alla quota maturata, a prescindere dall’esistenza di un atto con data certa. L’argomentazione principale è che il rinvio all’Art. 17, comma 1, lettera c) del TUIR nell’Art. 105, comma 4, serva unicamente a individuare le fattispecie deducibili nell’ambito degli “Accantonamenti di quiescenza e previdenza”, senza imporre le condizioni specifiche previste per la tassazione separata dell’amministratore.
Nonostante la presenza di orientamenti giurisprudenziali più tolleranti, l’approccio più prudente e consigliabile per le imprese è quello di assicurare sempre l’esistenza di un atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto
Come documentare la “data certa”
La "data certa" di riconoscimento del TFM può essere attestata attraverso diverse modalità:
- da una clausola inserita nello statuto sociale; è condizione essenziale che venga indicata la misura dell’indennità o i parametri oggettivi per determinarla;
- da una delibera assembleare registrata;
- tramite invio della delibera assembleare tramite PEC;
- notifica formale all’amministratore mediante raccomandata in plico (senza busta);
- estratto notarile del libro delle delibere assembleari;
- scrittura privata autenticata.
Un ulteriore aspetto critico emerge dall’Ordinanza della Cassazione n. 19445 del 10 luglio 2023. Questa pronuncia ha specificato che, se l’attribuzione del TFM all’amministratore avviene contestualmente alla sua nomina in assemblea, non si configura un atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto. Ciò significa che la mera inclusione della previsione del TFM nella delibera di nomina non è sufficiente.
Per garantire la deducibilità per competenza e la tassazione separata, l’atto che stabilisce il diritto al TFM deve precedere effettivamente l’inizio formale del mandato dell’amministratore; pertanto, le società sono tenute prima a formalizzazione il diritto al TFM con data certa (ad esempio, tramite una delibera precedente o una clausola statutaria già in essere), e solo successivamente deve intervenire l’accettazione dell’incarico da parte dell’amministratore.
| Requisito | Deducibilità per la società | Tassazione per gli amministratori |
|---|---|---|
| Data certa | Per competenza o per cassa | Tassazione separata oppure ordinaria |
L’importo del TFM: il principio di ragionevolezza ed il limite di un milione di euro
La quantificazione del TFM è lasciata alla libera contrattazione delle parti, ma è fondamentale che l’ammontare sia determinato tenendo conto di un criterio di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell’impresa. Si devono valutare elementi come le dimensioni aziendali, il fatturato, il reddito e la complessità dell’attività svolta dall’amministratore. L’orientamento giurisprudenziale prevalente contrasta la tesi dell’Agenzia delle Entrate che talvolta ha ritenuto parzialmente indeducibile l’accantonamento al fondo TFM, applicando analogicamente il limite di deducibilità previsto per il TFR dei lavoratori dipendenti. Sul punto la giurisprudenza ha ribadito che il legislatore non ha posto un tetto massimo di deducibilità per il TFM e che pertanto l’accantonamento non deve necessariamente essere limitato al valore convenzionale previsto per i lavoratori subordinati (13,5 mensilità).
Per quanto riguarda la possibilità per l’amministratore di avvalersi della tassazione separata all’atto della percezione del TFM, occorre ricordare che un cambiamento significativo è stato introdotto dal D.L. n. 201/2011 (Decreto Salva Italia), entrato in vigore il 6 dicembre 2011. Questo decreto ha stabilito un limite di un milione di euro per l’applicazione della tassazione separata. Ciò significa che per importi di TFM superiori a questa soglia la parte eccedente è in ogni caso assoggettata a tassazione ordinaria IRPEF, anche in presenza di atto con data certa.
| Requisito | Per la Società (Deducibilità) | Per l’Amministratore (Tassazione) |
|---|---|---|
| Limite di 1 milione di euro | Non applicabile (la giurisprudenza ha escluso limiti analoghi al TFR) | Sì, la parte eccedente è soggetta a tassazione ordinaria |
Rinuncia al TFM: le conseguenze
La rinuncia al TFM da parte dell’amministratore ha diverse implicazioni fiscali, variabili a seconda che l’amministratore sia anche socio della società, o meno.
Quando un amministratore, che è anche socio, rinuncia al TFM, questa rinuncia viene interpretata come un conferimento a patrimonio netto della società. Di conseguenza, tale rinuncia non genera sopravvenienze attive tassabili per la società. Questo perché essendo il TFM un credito vantato da persona fisica non esercente un’attività d’impresa, non è ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale. La volontà sottostante è quella di patrimonializzare la società; di conseguenza la rinuncia comporta l’aumento del costo della partecipazione detenuta dal socio.
Secondo un primo orientamento dell’Amministrazione Finanziaria e della giurisprudenza, per l’amministratore socio i crediti rinunciati si intendevano comunque giuridicamente incassati e quindi assoggettati a tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori, con l’obbligo per la società di effettuare la ritenuta alla fonte. Tale interpretazione era supportata, ad esempio, dalla Risoluzione n. 124/E del 13 ottobre 2017 e dall’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1335 del 26 gennaio 2016.
Tuttavia l’Ordinanza della Cassazione n. 16595/2023 ha rappresentato un vero e proprio superamento definitivo della "fictio iuris dell’incasso giuridico" per i soci amministratori che rinunciano a crediti tassati per cassa, come il TFM, affermando che la rinuncia non comporta un arricchimento tassabile per il socio, poiché non vi è un incremento patrimoniale effettivo.
Se a rinunciare al TFM, invece, è un amministratore che non è anche socio, il discorso cambia. In questo caso, se la società ha dedotto le quote accantonate in esercizi precedenti, la rinuncia genera una sopravvenienza attiva tassabile per la società, aumentando il reddito imponibile dell’azienda (anche in caso di avvenuta adesione al CPB, posto che le sopravvenienze attive sono variabili che rettificano in aumento il reddito concordato). Per l’amministratore non socio, in assenza di una contropartita (non potendo incrementare il valore di una partecipazione), il principio dell’incasso giuridico non si applica a prescindere, e l’amministratore non sarà assoggettato ad alcuna imposizione fiscale sulla rinuncia.
| Soggetto che rinuncia | Effetti Fiscali per la Società | Effetti fiscali per l’Amministratore |
|---|---|---|
| Amministratore-Socio | Nessuna sopravvenienza attiva tassabile (interpretata come conferimento a patrimonio netto ex Art. 88, co. 4-bis TUIR) | Nessuna tassazione (superamento del principio dell’incasso giuridico per effetto Cass. n. 16595/2023). Aumento del costo della partecipazione. |
| Amministratore non Socio | Sopravvenienza attiva tassabile (se le quote erano state dedotte negli esercizi precedenti) | Nessuna tassazione (il principio dell’incasso giuridico non è applicabile) |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il Trattamento di Fine Mandato (TFM): deducibilità, importo e implicazioni della rinuncia