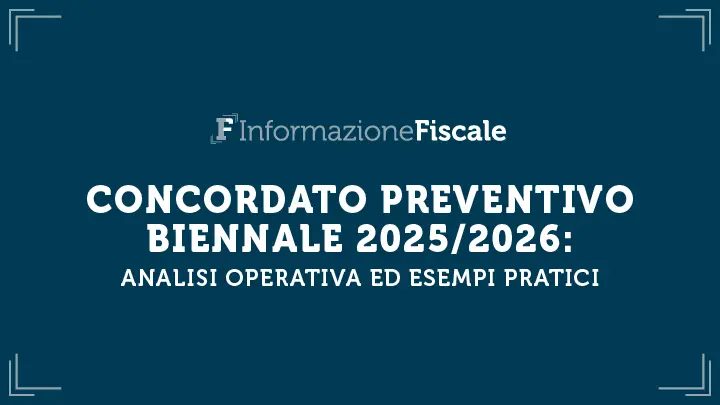È possibile chiudere l’esercizio in perdita e, contemporaneamente, dover versare le imposte su un reddito imponibile? Con il nuovo Concordato Preventivo Biennale, la risposta non solo è affermativa, ma nasconde complessità operative che ogni professionista deve conoscere

L’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) introduce per i contribuenti un percorso di definizione biennale del reddito, ma non esclude la possibilità che, nell’arco del periodo di validità dell’accordo, possano emergere delle perdite fiscali.
Questa circostanza, apparentemente in contraddizione con la logica del reddito minimo concordato tassabile (2.000 euro), espressamente previsto dal decreto legislativo 13/2024, trova una sua precisa disciplina normativa e richiede un’attenta analisi, in quanto, istintivamente, è difficile immaginare la coesistenza nel medesimo periodo di imposta di reddito tassabile e di una perdita a riporto.
Dal reddito concordato al reddito (o alla perdita) fiscalmente rilevante
Il cuore della questione risiede nelle cosiddette “variabili non concordabili” L’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 13/2024 stabilisce che l’accettazione della proposta vincola il contribuente a dichiarare gli importi concordati.
Tuttavia, gli articoli 15 e 16 del medesimo decreto specificano che dal reddito concordato devono essere escluse alcune componenti di natura straordinaria, che rettificano in aumento o in diminuzione il reddito da assoggettare a tassazione.
È proprio la presenza di significative rettifiche in diminuzione che può portare il risultato d’esercizio ad assumere valore negativo, seppure il contribuente abbia sottoscritto il concordato preventivo.
In dettaglio, le variabili escluse dal reddito concordato sono:
Per il reddito d’impresa (art. 16, D.Lgs. 13/2024):
- Plusvalenze realizzate (artt. 58, 86 e 87 del TUIR) e sopravvenienze attive (art. 88 del TUIR).
- Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti (art. 101 del TUIR).
- Utili o perdite derivanti da partecipazioni in società di persone, G.E.I.E., o società di capitali in regime di trasparenza (artt. 5, 115 e 116 del TUIR).
- Utili distribuiti da società ed enti (art. 73 del TUIR), secondo le regole degli artt. 59 e 89 del medesimo testo unico.
Per il reddito di lavoro autonomo (art. 15, D.Lgs. 13/2024):
- Plusvalenze e minusvalenze (art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR).
- Corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali.
- Redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone (art. 5 del TUIR).
Per completezza, si ricorda che a partire dal biennio concordatario 2025/2026 anche la cd.maxi-deduzione del costo del personale assunto a tempo indeterminato, in presenza di incremento occupazionale (art. 4 d.lgs. 216/2023) è entrata a far parte delle “variabili non concordabili”, così come disposto dall’articolo 13 del d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81.
Il reddito minimo e la formazione della perdita
Nonostante le rettifiche, l’articolo 16, comma 4, del D.Lgs. 13/2024 (decreto CPB) impone un reddito minimo imponibile di 2.000 euro. Ciò può dar luogo ad una situazione singolare, in cui il contribuente è tenuto a tassare un imponibile minimo pur avendo generato una perdita fiscale nell’esercizio.
Sul punto è intervenuta la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 17 settembre 2024.
Al paragrafo 3.2 “Reddito d’impresa oggetto di concordato” l’Agenzia ha chiarito il meccanismo, affermando che la normativa prevede la possibilità di riportare a nuovo le perdite fiscali che emergono a seguito delle rettifiche al reddito concordato.
La circolare ha concluso specificando che: “Per effetto delle disposizioni richiamate, il contribuente che si trova nella predetta situazione dichiarerà sia un reddito (pari per l’appunto a 2.000 euro), sia una perdita da riportare in avanti”.
Viene così ufficializzata la possibilità, per il contribuente in concordato, di generare una perdita riportabile ai periodi d’imposta successivi (ai sensi degli artt. 8 e 84 del TUIR), pur dovendo assoggettare a tassazione il reddito minimo di 2.000 euro.
L’opzione per la flat tax e le sue implicazioni
Un ulteriore elemento di complessità è rappresentato dalla facoltà di assoggettare a imposta sostitutiva (cd. “flat tax”) la quota di reddito concordato eccedente quello di riferimento del periodo precedente.
La Circolare 18/E/2024, al paragrafo 6.18, ha chiarito che l’opzione per la flat tax è indipendente dalle perdite, siano esse pregresse o di periodo.
Il flusso logico è il seguente:
- In presenza di opzione per la flat tax, il contribuente calcola l’imposta sostitutiva sulla differenza tra reddito concordato e reddito dell’anno precedente. Il restante reddito concordato viene poi rettificato dalle variabili non concordabili. Se il risultato è negativo, si genera una perdita riportabile, mentre l’imposta sostitutiva resta dovuta. In questo scenario, come chiarito anche nella risposta al quesito 6.17 della Circolare 18/E/2024, non si applica la tassazione minima di 2.000 euro, poiché l’imponibile su cui applicare l’IRES è azzerato dalla perdita.
- Senza opzione per la flat tax, l’intero reddito concordato viene rettificato dalle variabili non concordabili. Se emerge una perdita, scatta l’obbligo di tassare l’importo minimo di 2.000 euro, e la perdita riportabile a nuovo sarà conseguentemente incrementata.
Esempio e compilazione del quadro CP
Si ipotizzi una S.r.l. che ha aderito al CPB con i seguenti dati:
- Reddito di riferimento 2023 (P04 CPB): 60.000 euro
- Reddito concordato per il 2024 (P06 CPB): 90.000 euro
- Perdita su crediti deducibile nel 2024 (variabile non concordabile): 110.000 euro
Nel caso in cui il contribuente rinunci ad applicare la flat tax, la sezione I del quadro CP non sarà compilata. Nella sezione II, verrà esposta la perdita su crediti, che origina una variazione in diminuzione al reddito concordato di 110.000 euro.
La differenza tra reddito concordato e rettifiche porta ad una “perdita in regime di concordato” pari a € 20.000, ma nel capo CP7 Col. 5 (Reddito concordato rettificato) deve comunque essere indicato l’importo di € 2.000, in quanto scatta l’obbligo di tassazione minima come da art. 16, c. 4, D.Lgs. 13/2024.
In conclusione, la società dovrà versare l’IRES sul reddito minimo di 2.000 euro e, contemporaneamente, emergerà una perdita fiscale, riportabile a nuovo, di 22.000 euro (calcolata come differenza tra il risultato effettivo di -20.000 euro e i 2.000 euro assoggettati a tassazione).
Nel caso in cui, invece, il contribuente opti per la flat tax, ipotizzando che la società abbia un punteggio ISA 2023 pari a 9, che dà diritto all’aliquota flat tax del 10 per cento (art. 20-bis, D.Lgs. 13/2024), nella sezione I del quadro CP viene determinata l’imposta sostitutiva dovuta (€ 90.000 - € 60.000 = € 30.000 x 10 per cento = € 3.000). Nella sezione II il reddito concordato residuo (al netto della quota già tassata a flat tax) viene rettificato della perdita su crediti (€ 60.000 - € 110.000 = -€ 50.000).
In conclusione, in questo scenario l’azienda versa, nell’immediato, una somma certamente complessivamente maggiore rispetto al caso di rinuncia alla flat tax ma, di per contro, riporta a nuovo una perdita di 50.000 euro invece che di 22.000 euro, perdita che consentirà in futuro un risparmio IRES.
In definitiva, la gestione di una perdita in regime di concordato pone il contribuente di fronte a un bivio strategico:
- minimizzare l’esborso fiscale immediato rinunciando alla flat tax, a costo di una minore perdita riportabile;
- oppure massimizzare la perdita futura da utilizzare a scomputo dei redditi successivi, accettando un onere fiscale immediato più elevato.
La scelta, tutt’altro che banale, richiede un’attenta pianificazione fiscale basata sulle aspettative di redditività future dell’impresa.
Per approfondire ulteriormente i vantaggi e il risparmio fiscale ottenibile con il concordato preventivo biennale per le partite IVA puoi acquistare il nostro corso operativo ricco di spunti davvero utili:
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La gestione della perdita in regime di concordato